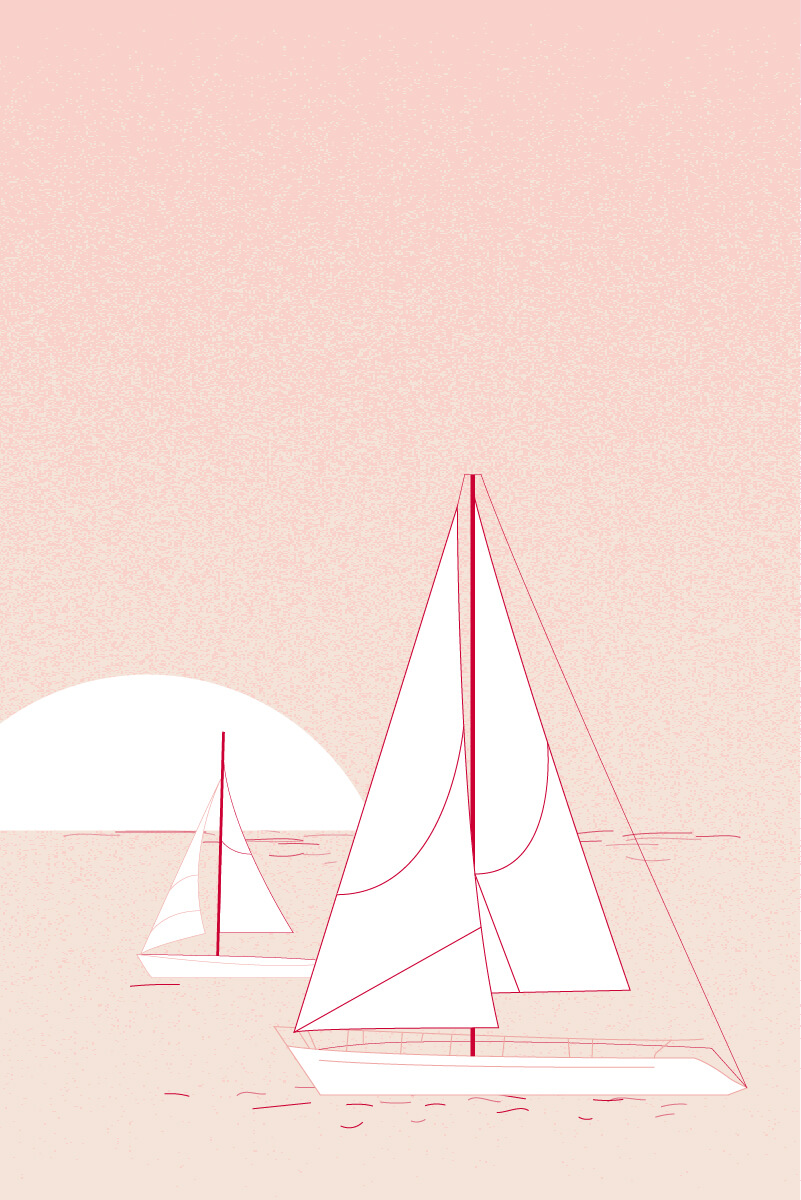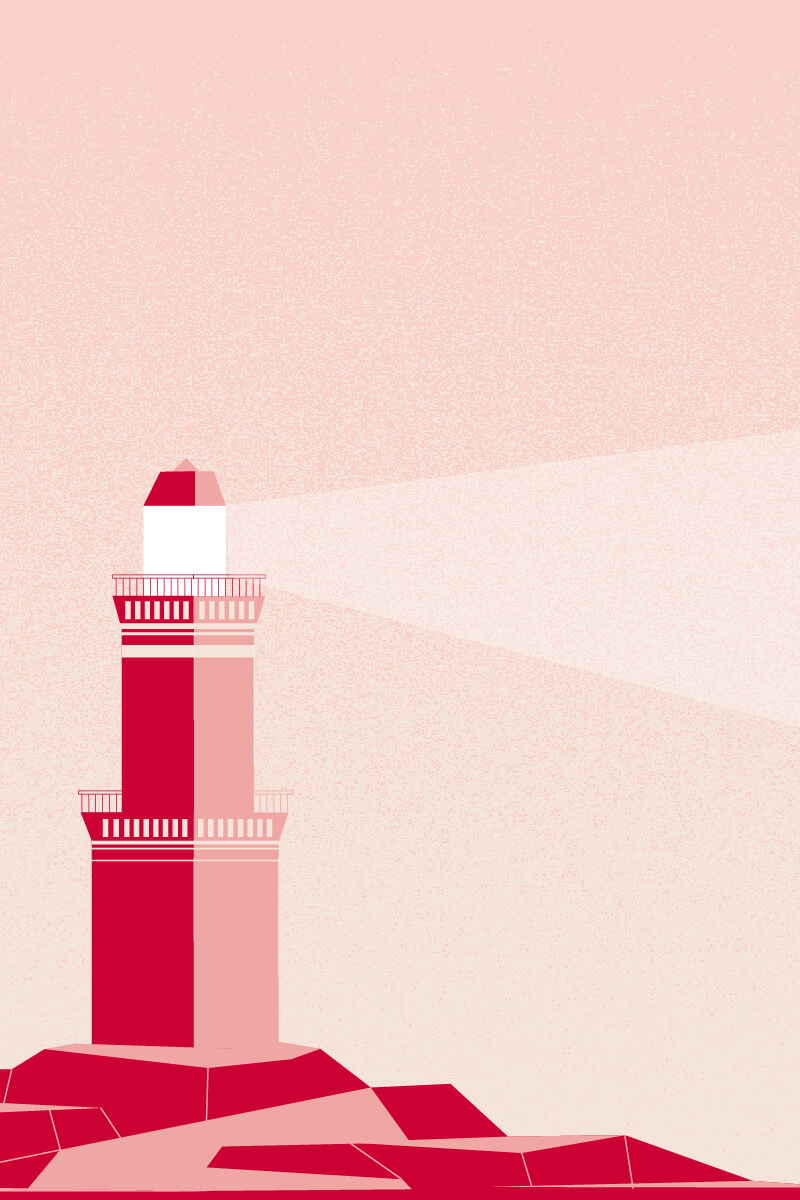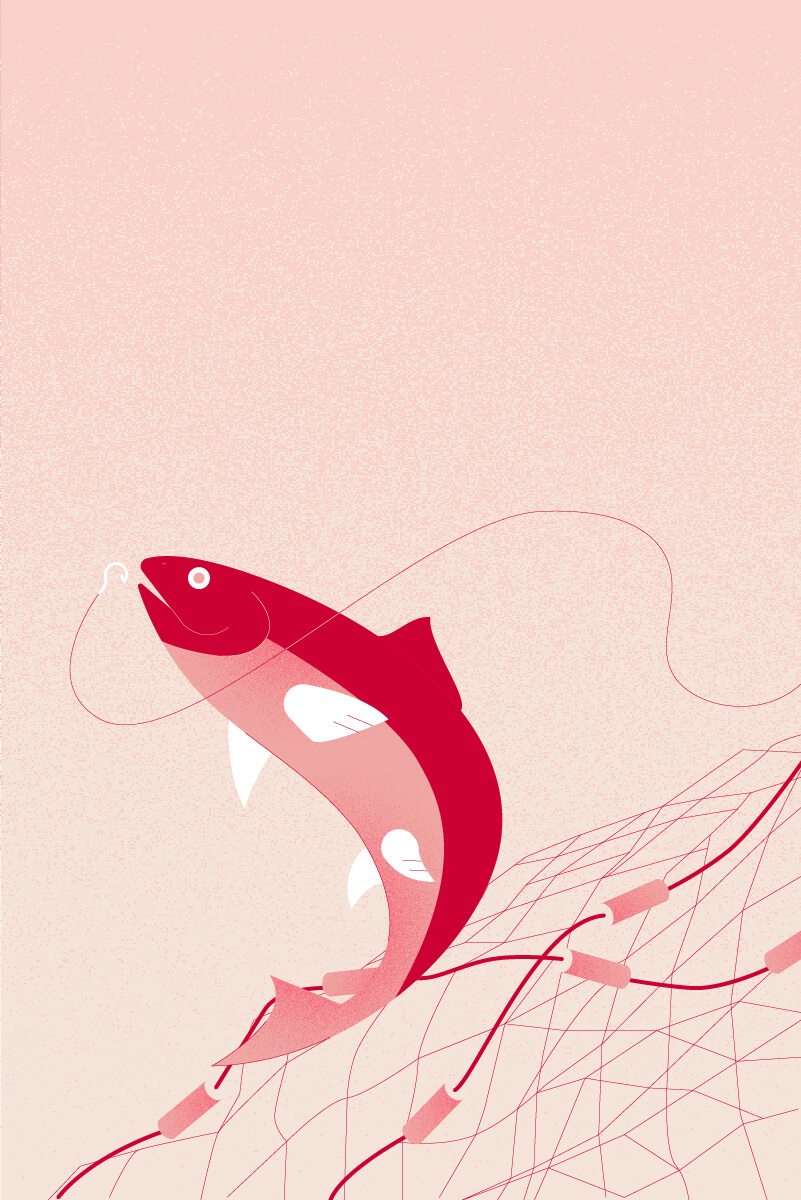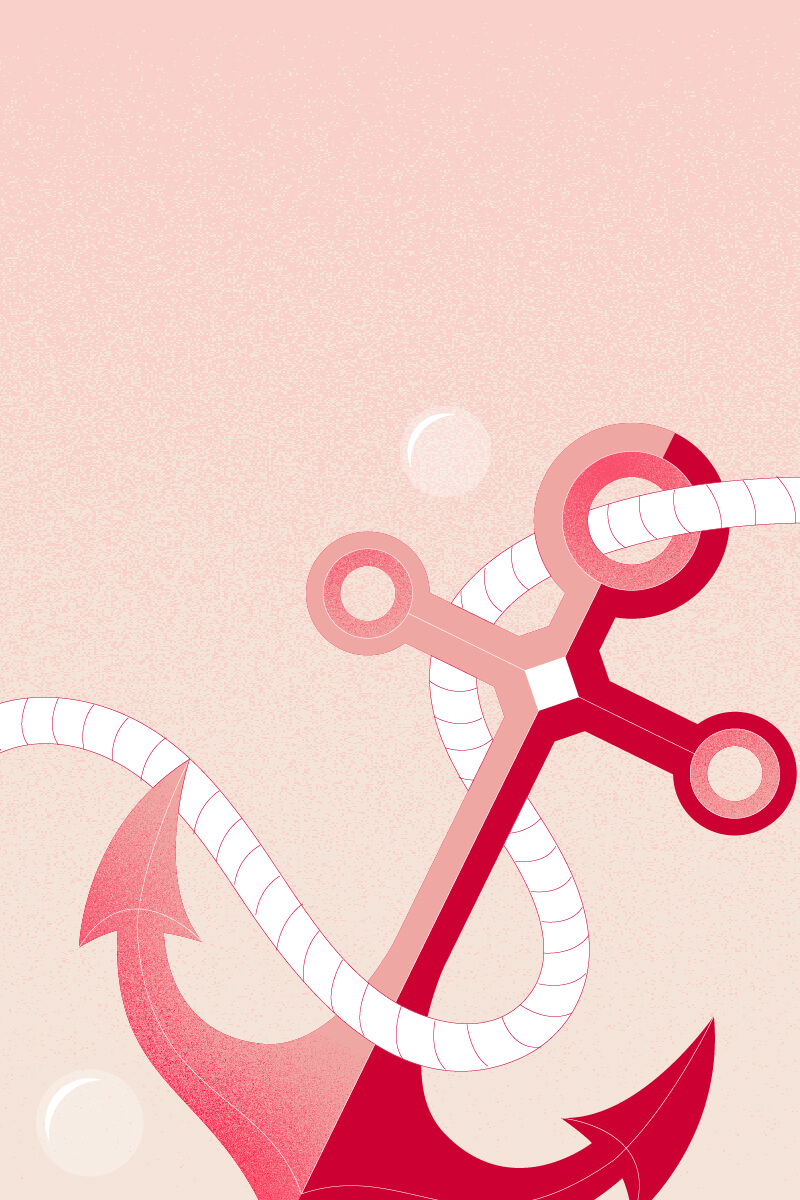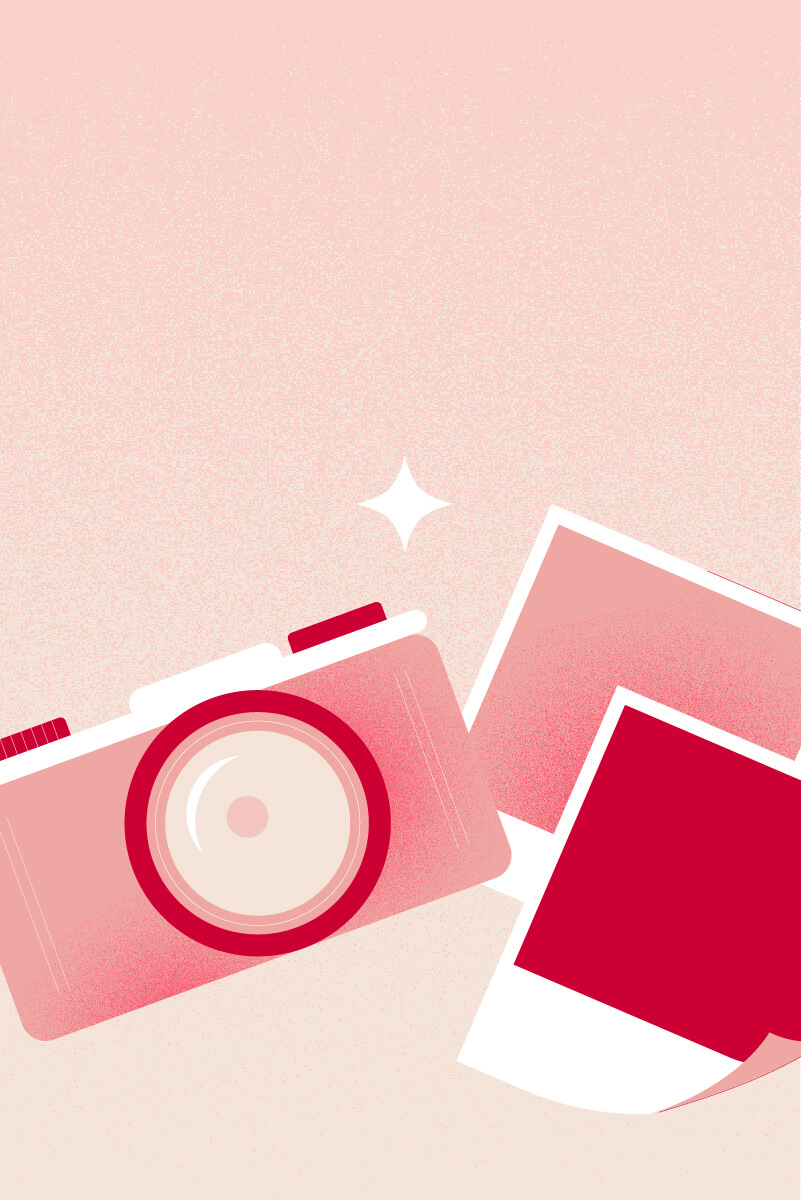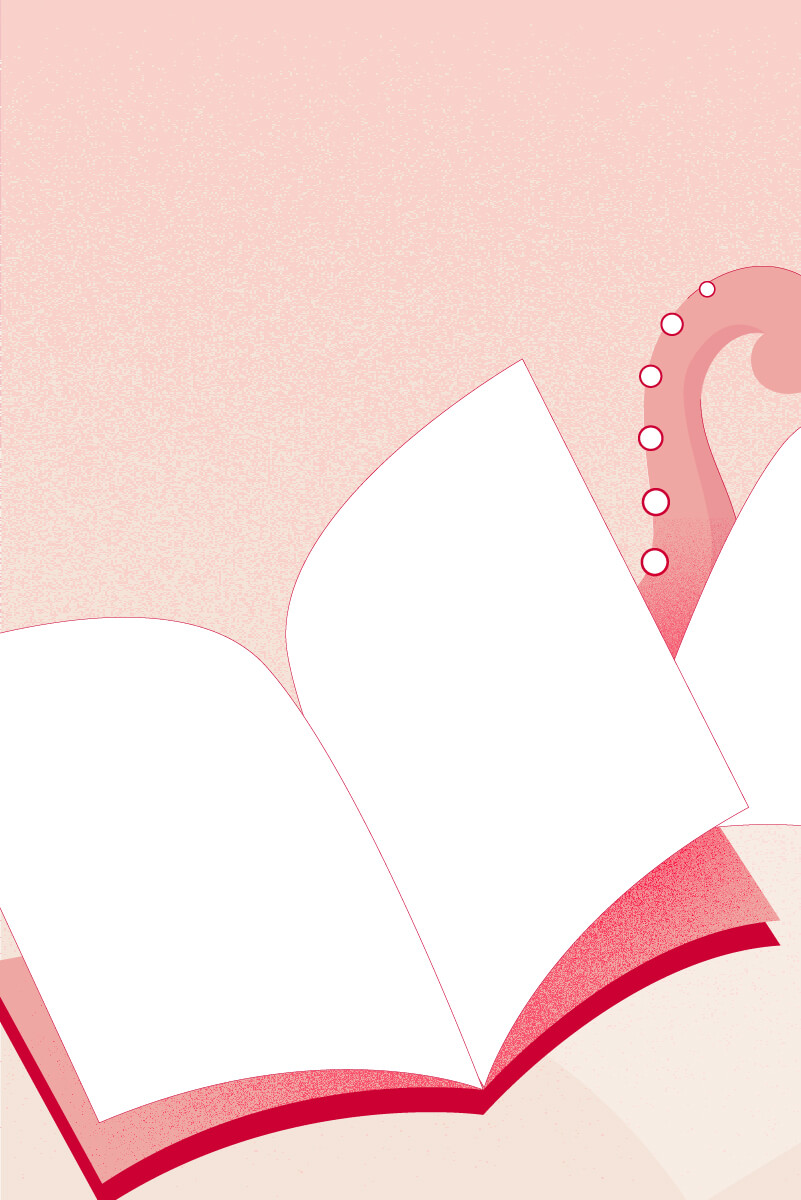Post trivelle: dopo il referendum, che cosa c’è da sapere sull’attività estrattiva in Italia?
Dopo il referendum del 17 aprile scorso delle trivelle non si è più parlato, ma le attività estrattive nel Mediterraneo sono ancora oggetto di critiche.

Dopo il referendum del 17 aprile scorso delle trivelle non si è più parlato, ma le attività estrattive nel Mediterraneo sono ancora oggetto di critiche.
- Quante sono le trivelle nel Mediterraneo: il dossier di Greenpeace
- Nuove trivelle in arrivo
- Danni ambientali: reali o presunti?
- Estrarre quantità piccole, per un grande danno ambientale
- Crisi del greggio: a rischio molti posti di lavoro
- Il fenomeno della subsidenza
- Abbandonare le trivelle, sostenere l'energia pulita
Come tutti sappiamo, il referendum del 17 aprile sulle trivellazioni nel mar Mediterraneo non ha raggiunto il quorum e la situazione delle perforazioni nel nostro mare non è cambiata. Liguria Nautica si era già occupata della questione, spiegando nel dettaglio che la vittoria del SÌ al Referendum avrebbe significato l’abrogazione di quella parte di legge di stabilità del 2016 che riguarda le attività estrattive. Secondo il nuovo testo, le concessioni non hanno bisogno di essere rinnovate fino all’esaurimento dei giacimenti. Precedentemente, invece, le piattaforme potevano essere sfruttate per 30 anni, poi c’era bisogno della proroga, di durata di 10 anni (5+5).
Quante sono le trivelle nel Mediterraneo: il dossier di Greenpeace
Il quorum non è stato raggiunto e l’attenzione sulle trivelle è calata velocemente. Greenpeace, però, è tornata sulla questione, con un dossier, #Dismettiamole, pubblicato lo scorso agosto. Il rapporto, profondamente critico nei confronti delle attività estrattive, delinea innanzitutto un quadro generale di tale pratica nei nostri mari. Le concessioni di coltivazione sono 69, di cui 20 non produttive. Le piattaforme sono ben 135, per un totale di 729 pozzi. La maggior parte sono concentrate nell’alto Adriatico e producono gas (39), altre 20 nell’Adriatico centrale tra l’Abruzzo e le Marche, 4 si trovano nel canale di Sicilia, 4 nel Mar Ionio e le ultime 2 fra il basso Adriatico e lo Ionio. Di queste, 44 sono all’interno del confine delle 12 miglia (e sono quindi quelle di cui parla la legge di stabilità), mentre le restanti 25 sono al di fuori di tale limite. Secondo l’elaborazione dei dati dell’Ufficio Nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, effettuata da Legambiente, delle 135 piattaforme a mare e dei 729 pozzi presenti, ben 54 hanno più di 30 anni, mentre le 4 piattaforme più recenti, che si trovano di fronte alla costa marchigiana, sono state realizzate dall’ENI fra il 2014 e il 2015.
Nuove trivelle in arrivo
Nel dossier di Greenpeace si sottolinea anche che esiste il rischio di nuove trivellazioni. Oltre ai 22 permessi di ricerca recentemente rilasciati, sono state avanzate 4 richieste di concessione di coltivazione e 32 istanze di permesso di ricerca, consegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. Infine, le 8 istanze di permesso di prospezione, per cercare nuovi giacimenti, prevedono l’utilizzo della tecnica dell’airgun, che è fortemente impattante sia per l’ambiente sia per la fauna marina.
Danni ambientali: reali o presunti?
I problemi legati alla presenza di tali strutture riguardano sia quelle attive, sia quelle ormai inattive. Iniziamo dalle piattaforme inattive, di cui Greenpeace sollecita lo smantellamento (decommissioning). L’avvio a dismissione di tali impianti è considerato dall’associazione ambientalista fondamentale, in particolare per le strutture sotto costa. Fra queste, nel rapporto viene citata la piattaforma di estrazione Angela Angelina, costruita nel 1997 a soli 2 km dal Lido Dante, a Ravenna. La piattaforma è collegata a 10 pozzi attivi e a 4 non eroganti ed è stata al centro del dibattito referendario a causa dei suoi effetti sull’aumento della subsidenza (abbassamento del fondale marino). L’amministrazione di Ravenna si è impegnata lo scorso aprile ad avviare con Eni un percorso per la chiusura anticipata dell’impianto, ma ancora oggi niente è stato fatto. Secondo quanto sostenuto da un geologo, impiegato presso una delle maggiori aziende estrattive, che ci ha chiesto di rimanere anonimo, le piattaforme inattive non causano danni all’ambiente. «È vero», ha ammesso nell’intervista, «che spesso le aziende ritardano il decommissionamento, dal momento che si tratta di operazioni costose e che non arrecano alcun vantaggio economico ai produttori. Tuttavia, non si può sostenere che la loro permanenza sia dannosa per l’ecosistema marino o per quello costiero», ha spiegato. Secondo Greenpeace, invece, gli impianti inattivi rilascerebbero nell’acqua sostanze cancerogene, che attraverso i micro organismi marini arriverebbero addirittura fino all’uomo. «Ci sono esagerazioni e manipolazioni da entrambe le parti», ha commentato ancora il geologo, citando a sostegno della sua tesi la coltivazione di cozze che è sorta proprio su una piattaforma inattiva, a Ravenna. I prodotti della cooperativa allevamenti di militi in mare sono sottoposti a controlli regolari, da parte delle AUSL, per effettuare l’analisi delle biotossine (ogni settimana), batteriologiche (ogni mese) e chimiche (ogni sei mesi). In caso di risultati positivi, la commercializzazione del prodotto viene subito interrotta. Dal 1991, è successo solo una volta, nel 2015, che una parte delle cozze risultasse contenere troppo piombo.
Estrarre quantità piccole, per un grande danno ambientale
La questione delle piattaforme attive risulta invece più problematica. I motivi principali per cui Greenpeace è contraria all’attività estrattiva sono la sua scarsa utilità dal punto di vista economico e l’elevato danno ambientale che provoca. La produzione di greggio in mare è pari al 13,8% di quella totale, calcolata fra mare e terra. Una piccola percentuale, che diventa ancora più piccola (1,8%) se la si paragona ai consumi nazionali di petrolio. Anche le estrazioni di gas soddisfano solo una piccola percentuale del nostro fabbisogno, pari al 6,7%. Il ragionamento degli ambientalisti è chiaro: non vale la pena di fare fronte a danni ambientali di così grande entità, per estrarre quantità irrisorie di petrolio e di gas. Il discorso del geologo, invece, è un po’ diverso: «È vero che si tratta di piccole quantità», ammette, «Ma da tutti i giacimenti viene estratta solo una piccola percentuale del totale. Si potrebbe fare questo discorso per tutti gli impianti, con il risultato che l’attività estrattiva risulterebbe irrisoria ovunque», spiega. Tranne i grandi produttori, come per esempio l’Arabia Saudita, tutti gli altri Paesi hanno campi piccoli. L’Italia in particolare ha molte coltivazioni di dimensione ridotte, ma che insieme producono una parte considerevole del greggio e del gas che usiamo. «Bisogna ricordare», precisa il geologo, «che già un 2% è tanto: è come se si parlasse del calo del PIL, o dell’aumento della rata del mutuo: sembrano piccole cifre percentuali, ma in realtà in valori assoluti rappresentano numeri enormi». «Inoltre», continua l’intervistato, «il km 0 è un concetto che vale anche per gli idrocarburi. Il trasporto in mare del petrolio ha costi ambientali ingenti, in Italia i controlli sono maggiori che in altri Paesi, e di conseguenza i danni ambientali minori». Ma non è solo una questione di trasporto, ma anche di qualità del prodotto estratto: «Il petrolio che viene da fuori spesso è più sporco, e necessita di una lavorazione più lunga rispetto a quello estratto nei nostri mari», spiega il geologo. Infine, va fatta anche un’ulteriore considerazione: «Se l’Italia smettesse di estrarre petrolio, il prezzo sui mercati internazionali non subirebbe variazioni, essendo il Paese solo un piccolo produttore», conclude nell’intervista.
Crisi del greggio: a rischio molti posti di lavoro
Greenpeace sottolinea anche che il settore estrattivo è in crisi da tempo: non solo i consumi nazionali sono in calo (-21,6% per il gas e -33% per il petrolio), e molti posti di lavoro sono conseguentemente a rischio. Secondo la società di consulenza Deloitte, inoltre, a causa del crollo dei prezzi del petrolio il 35% delle compagnie petrolifere è a rischio fallimento nel 2016, con un debito accumulato che complessivamente raggiunge i 150 miliardi di dollari. Ne è una dimostrazione la crisi di Halliburton, Baker Hughes e Schlumberger, che nel giugno scorso hanno ridotto il personale degli impianti di Ravenna del 50%.
Il fenomeno della subsidenza
Infine, come accennato in precedenza, non bisogna sottovalutare il fenomeno della subsidenza, ossia l’abbassamento della superficie topografica, dovuta all’attività estrattiva, che aumenta l’impatto delle mareggiate e delle piene fluviali, favorendo l’erosione costiera. Questo danneggia anche le attività turistiche, con un danno economico che non viene recuperato dai proventi del petrolio e del gas.
Abbandonare le trivelle, sostenere l’energia pulita
La situazione, insomma, è tutt’altro che lineare e di facile comprensione. Secondo Greenpeace, però, la cecità del Governo rispetto alla crisi del settore estrattivo si traduce nell’assenza di una reale politica energetica e quindi nella mancata tutela di un’ampia fascia di lavoratori che rischia di rimanere a casa. Il problema dei danni ambientali e della crisi economica del settore estrattivo potrebbe essere risolta prestando un occhio di riguardo al settore delle energie rinnovabili, che al contrario è in forte crescita. Lo sostiene anche la Fiom, che, come riporta il dossier di Greenpeace, ha calcolato che nel solo settore delle energie rinnovabili potrebbero essere ricavati, entro il 2030, addirittura 600mila posti di lavoro.
Ilaria Bucca
Argomenti: ambiente-&-sostenibilità, Daily Nautica